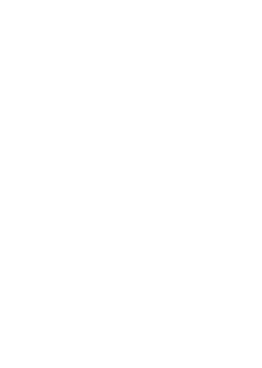Un luogo e una cucina indissolubilmente legati: il futuro di piatti icona e ricette che affondano le radici nell’Al Andalus è nelle mani di giovani grandi chef radicati nella città della Moschea Cattedrale.
Una sfilata di 850 colonne alla Mezquita, un labirinto di mosaici bizantini e una nuova visione di cucina: questa è Cordoba, dove negli ultimi millenni Fenici, Romani e Arabi hanno costruito la Spagna gastronomica, inventando banchetti sempre più sofisticati. Tracce riprese nel ventunesimo secolo per rinfrescare la tradizione della città, con la sua storia e i suoi piatti iconici: le creme fredde per l’estate e per l’inverno, prima fra tutte il salmorejo. Pasto utile a sfamare le truppe romane, nasce dal primitivo istinto dell’uomo di triturare gli ingredienti per mescolarli tra loro, ma anche dall’abitudine di usare il pane come base principale di tantissime pietanze. Bianco quindi in origine: l’aggiunta del pomodoro, infatti, avviene solo molto dopo la colonizzazione del centro sud America e ci guadagna l’estetica delle sfumature.

Il salmorejo appartiene alla famiglia dei gazpachos, ma ha qualche ingrediente in meno e una consistenza più cremosa. Composto da pane, pomodoro, aglio, olio, aceto e sale, veniva lavorato al mortaio, e ricorda il formaggio spalmabile dell’antica Roma, il moretum che Ovidio e Virgilio raccontano nei loro poemi. Conoscere queste origini permette ai protagonisti dell’attuale panorama gastronomico cordovano di rispettarle, ma tanto più di stravolgerle. Come fa lo chef Juan José Ruiz, che sfida la tradizione con La Salmoreteca al mercato gourmet Victoria, che insieme a quello di Los Patios de la Marquesa (a pochi passi dalla Mezquita) arreda e riscalda il cuore di Cordova. Juan, dopo la disciplina dei maestri stellati, esce dagli schemi e azzarda versioni di salmorejo tra aromi agli agrumi e note di cioccolata. Juan interpreta infatti questo piatto come una tela bianca su cui miscelare vertigini e gioia, uno spazio da spennellare con gusto e fantasia. È fiero della sua interpretazione: usa il mortaio, come una volta, e sceglie un olio speciale dal doppio cromosoma di cultivar, ma ammette: «Come quello di mia nonna non ce n’è!». Ma se c’è un’intera tradizione da raccontare, perché fermarsi a un solo luogo di narrazione culinaria? Juan affitta così la Casa de Manolete, palazzetto del 1890 in avenida de Cervantes 10 (all’angolo con calle la Bodega) per farne un nucleo di cultura e formazione gastronomica, con il Centro Superior de Artes y Ciencias Gastronómicas (Csacg), che avvierà la scuola di cucina il prossimo autunno, e due ristoranti con caratteri opposti: La Casa de Manolete Bistró, con un menù dinamico da provare nei suoi salotti in stile coloniale, e A Flor de Piel che, dopo un primo ricevimento in cortile e una visita alle sale, sfoggia in tavola l’alta cucina di Juan. Cambiando luogo, ma non fondamenta culturali, ecco che ritorna il salmorejo anche nel menù del Restaurante Choco di Kisko García, quarantunenne cordobés con spirito contemplativo e 1 stella Michelin cucita sul petto. Uno chef curioso che cucina non solo la sua città natale, ma ricerca i sapori di ogni zona dell’Andalusia e li ricama nel suo menù.
Ma qual è la vera essenza della regione? Kisko cerca la risposta sfogliado il suo estro gastronomico, senza mai perdere l’occasione di spiare sotto i vestiti della Cordova notturna: «I vicoli poco illuminati celano un’eterna chimera per la mia creazione». Merito delle civiltà che si sono ritrovate nel centro della città, un garbuglio che secolo dopo secolo ha impregnato l’aria di magia e stimoli culturali. Da Choco l’enfasi non si sfoga solo nel gusto, ma si evolve nella ricerca sinestetica, coinvolgendo tutti gli altri sensi, a partire dalla vista. Presentazioni su pietra, legno e altre piattaforme materiche, combinate con grezzi ceppi d’albero che creano quel calore che si trova solo a casa. Choco ha dovuto scalare gli anni di esperienza di quella che fu la taverna della famiglia García prima di imporsi come il ristorante moderno con mattoni a vista e chicche di design che oggi si sporge dal quartiere Polígono de la Fuensanta. Lo chef culla una trasgressione tecnica e sensoriale fino a risvegliarla dentro sensibili creazioni, come il salmorejo al amontillado Carlos VII, servito con una coca (una sorta di focaccia) minimale impreziosita con acciughe, erbette e fiori delicati. Una crema liquorosa per lo sherry di Montilla, sconosciuta quanto secolarmente legata a Cordova.

Se la crema di pane, aglio e olio, alle fondazioni del salmorejo, accetta ogni variante, Celia Jiménez la serve in versione mazamorra, altra icona cordobesa di precolombiana memoria, quando il pomodoro non aveva ancora attraversato l’Atlantico e nell’al’Andalus trionfava la mandorla. Una tavolozza candidamente bianca che la chef colora con una manciata di sottaceti e mela verde, profumando la brezza mandorlata con il refolo affumicato di una sardina. Un miscuglio di gusti che cresce, fra note amare, da una mollica di pane condita con aglio, olio e aceto. Nel ristorante che porta il suo nome, Celia miscela l’eredità andalusa, quella ebraica e pure la cristiana in uno spazio diafano nel complesso sportivo Open Arena. Qui, sulla strada per il sito archeologico di Madinat al’Zahra, si intraprende un tour gastronomico che sconfina nella tradizione. Si inizia con un aperitivo sulla terrazza e si prosegue con il menù degustazione della prima chef a ricevere il luminoso riconoscimento Michelin in tutta l’Andalusia. Là, nell’aulica residenza fatta costruire fra il 936 e il 948 dal califfo Abd al- Rahman III, scorci di marmo, ebano e avorio celebrano Zahra, la preferita delle concubine. Ciò che resta rimanda a un’epoca di grandezza, ai sontuosi banchetti di corte fra i ricami delle architetture patrimonio dell’Umanità. Anche da Celia, i piatti sorprendono con prelibatezze, ricordi e aromi del tempo districati nel consumo di olive, gustose e marinate, e un uso straordinario di ingredienti come riso, agrumi e spezie profumate. Aromi tipici di un suq che oggi evaporano anche nella cucina di un altro figlio di Cordova, lo chef Paco Morales.



Nel popolare quartiere di Cañero, il suo ristorante Noor – “luce” in arabo, «luce che durante oltre sette secoli di convivenza ha illuminato la cultura e la cucina andalusa» – regala un viaggio temporale nella Cordova dell’al-Andalus. Con tutta l’energia concentrata ne La Luz, la sala irradiata da un’aurora che abbraccia gli otto tavoli rivolti verso la cucina a vista, Noor non è solo un ristorante con una stella Michelin, ma un deposito di cultura che cammina imperterrito sulla strada dell’innovazione. Proietta infatti la cucina dal X al XV secolo nell’era contemporanea, con una proposta di assaggi gourmet che può essere compresa solo se si è al corrente della filosofia da cui nasce: «Conoscere la linea storica del lavoro è essenziale per poter creare». Un progetto gastro-culturale che scava nel passato e che «in un momento in cui gli chef hanno un’importante proiezione sociale, penso aiuti a diffondere la nostra cultura e la nostra storia» sostiene Paco Morales. Ogni stagione un nuovo menù, un secolo di sapori da scoprire grazie alla collaborazione con Rosa Tovar, studiosa e storica che sostiene la sua idea fin dalle prime due edizioni: Anno 0 con il menù “Califato de Córdoba” (X secolo), per rivivere i banchetti di Madinat al-Zahra; Anno I con “Reinos de Taifas” (XI secolo), i regni musulmani formatisi al dissolvimento del califfato nel 1031. Per Anno II (2018-2019) il menù “Imperios” è declinato, come sempre, in tre viaggi, quasi etnografici: Bereber, Tuareg e Almorávide. Ricrea la multiculturalità, la raffinatezza delle ricette e del servizio profusi al tempo degli imperi berberi degli Almoravidi e degli Almohadi, raccontando con ogni portata l’evoluzione e i gusti dell’epoca. Fra le entrate ittiche il bonito, sgombride in cubetti semiseccati con il sale, serviti su toast al limone bruciato e guarniti con perle di albaqdunis (una maionese di prezzemolo), accompagnati da una rinfrescante salsa di cetriolo, menta e arancia. Segue, nella tradizione delle creme di frutti secchi, il karim di mandorle tostate con riccio del Sahara (teff), mela verde e sommacco. Dalla crema di spinaci con formaggio di pecora, noci fresche e olio al rosmarino al foie gras arrosto seguito dall’ostrica con gelatina di agnello e granita di kefir, è un’escalation che si conclude nel dessert, che battezza la versione più lunga del menù con l’algarroba almorávide, la carruba andalusa che sorprende i palati moderni fingendosi cioccolato, dolce del tutto inesistente ai tempi dell’emirato berbero. Come può una cucina essere così intimamente legata a una città, e viceversa? C’è da chiedersi piuttosto che cosa accadrà domani, perché si guarda sempre avanti, ma come dimostra Cordova avrebbe più senso girarsi indietro a osservare. Provare a iniziare dalla fine, per sorprendersi di nuovo di come si è arrivati fino a qui, mangiando e pestando cultura al mortaio.

Pubblicato su Meridiani, luglio 2019, scritto in collaborazione con Carlo Spinelli.